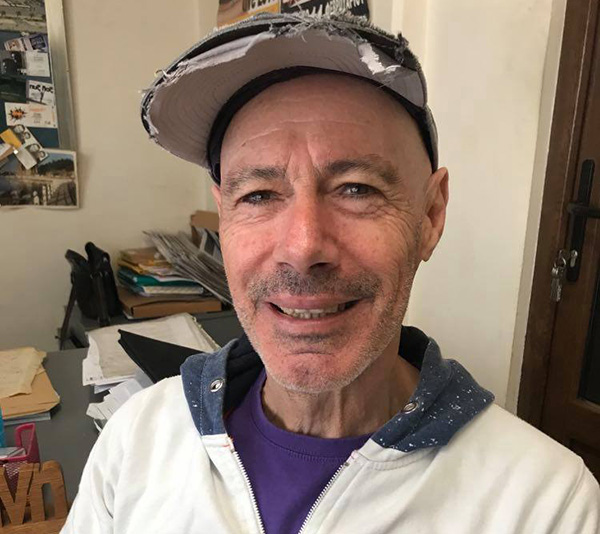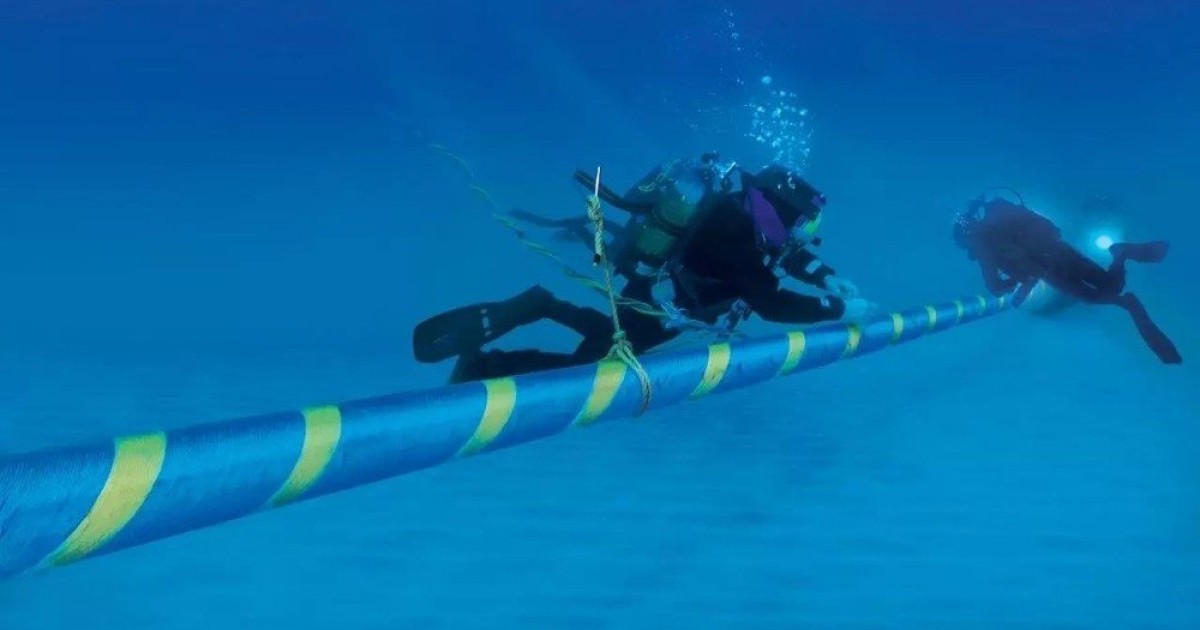Quale pensi sia il rapporto tra la parola resistenza, che non significa solo “no”, e la parola disobbedienza?
C’è una connessione tra i due, con un solo problema che riguarda il caso Messico e non solo. Per entrare nella forma della disobbedienza politica, ci deve essere prima l’obbedienza politica. Non ce ne sono molti in Messico, il che significa che non abbiamo una tradizione di obbedienza politica. Siamo disobbedienti in ogni modo. A volte in modo irrazionale e imbarazzante: a Oaxaca il modo di non rispettare le regole di passaggio rende molto pericoloso il traffico ma anche il camminare in città, ma allo stesso tempo ci sono luoghi di libertà che abbiamo creato, disattendendo le leggi e regolamenti che ci hanno imposto di vivere. Abbiamo resistito Leggi dell’India Leggi dell’India per trecento anni. Erano regole imposte dall’esterno, e poi abbiamo resistito alla legislazione dello stato messicano, che a sua volta è fatta di regole imposte dall’esterno. Abbiamo messo a confronto le norme attuali con le nostre, che risultano dalle forme di organizzazione, dalle culture indigene e non. Quindi, mentre posso certamente vedere che resistenza e disobbedienza sono collegate, in questo caso non è tanto vero perché siamo davvero e non siamo mai stati disobbedienti.
Un’altra preoccupazione ricorrente nei tuoi scritti recenti è quella della precarietà. In Italia, questa parola è stata usata per tentare di ricostruire un soggetto potenzialmente rivoluzionario, almeno sul piano teorico e politico. Tuttavia, come hai detto, siamo in una forte impasse politica dove, in pratica, spesso “bussiamo alla porta del capitalista” per chiedere un lavoro, e non necessariamente per creare alternative. Nei tuoi scritti parli di costruzione di sfere comunitarie, ma sempre nei termini di ciò che Ivan Illich chiama “de las herramientas”, il controllo sugli strumenti. Ciò solleva due domande. Il primo, più teorico, riguarda il rapporto tra la concezione di Illich della padronanza degli strumenti e la concezione di Marx della padronanza dei mezzi di produzione. La seconda, invece, riguarda maggiormente il tema della precarietà e si pone la questione di come, in una crisi economica come quella attuale, si possano creare il più possibile spazi comunitari e quindi strumenti di controllo..
Questo è un argomento che mi interessa e su cui ho riflettuto molto ultimamente. Per due anni mi è stato chiaro che i marxisti non leggono Illich e gli illichi non leggono Marx. E penso che sia una tragedia perché non leggere Illich ci impedisce di capire Marx e viceversa. C’è una connessione molto profonda tra i due e la combinazione dei due ci offre armi molto potenti per trasformare il presente. Per dirla in termini concreti, nel 1971 Illich produsse un breve trattato, una dissertazione, che avrebbe discusso nei suoi seminari settimanali per i successivi tre anni. Questa dissertazione afferma essenzialmente che per ristrutturare la società dobbiamo pensare a tre cose: 1. Il controllo sociale della proprietà dei mezzi di produzione. 2. nel controllo sociale sul frutto della produzione (la forma di distribuzione) 3. nel tetto tecnologico comune, cioè nei limiti che dobbiamo porre alla tecnologia per controllare il modo di produzione stesso, non solo la forma in cui è organizzato. Dopo il 1960, aggiunge, è diventato prioritario sottolineare il terzo punto, ovvero la limitazione della creazione tecnologica e il controllo del modo di produzione stesso, e che solo tre cose insieme possono consentire una ristrutturazione della società. Qui vedo un legame chiaro e profondo tra Marx e Ilic: l’intera costruzione illirica, come ha fatto per i successivi cinquant’anni, ha lavorato proprio in questa dimensione di controllo sui mezzi di produzione. Ma cosa significa? Primo, che tutte le istituzioni sovrane, tutti gli strumenti sovrani, diventino controproducenti, cioè producano il contrario di ciò che affermano di voler produrre (il trasferimento rapido sarà paralizzante, le scuole produrranno ignoranza e disuguaglianza, il sistema sanitario trasmetterà patologia). Secondo, dice Illich, stiamo perdendo il controllo delle istituzioni. Le istituzioni diventano un sistema. Invece di essere dentro, le cose che corrispondono alle mie intenzioni (se ho un martello, voglio che il martello faccia quello che voglio) vengono trasformate e asservite ai nostri stessi media. Questi saranno quelli che ci imporranno la loro logica. Questa posizione di Illich è la continuazione dell’idea di Marx, la sua realizzazione cento anni dopo. Credo quindi che dobbiamo riappropriarci di questi tre aspetti, che sono fondamentali per realizzare oggi una profonda trasformazione. Tornando allo zapatismo, non è altro che: il controllo completo sulla proprietà dei mezzi di produzione, una forma fantasticamente organizzata di distribuzione dei frutti del lavoro collettivo e il controllo completo sulla tecnologia utilizzata. I tre punti di Illich sono ben incarnati nel mondo zapatista.
Al contrario, la questione della precarietà, la precarietà. Questo termine, divenuto nel frattempo di moda in Europa, corrisponde al tentativo di riportare nel modello abituale i precari, che si discostano dal modello normale. Se solo si dicesse che coloro che sono diventati o sono sempre stati precari sono tanto sfruttati dal capitale e quindi parte del proletariato nel suo insieme, allora sì, quella sarebbe una posizione chiara. Si dice da tempo che i precari provenissero dallo sfruttamento capitalista, quindi è bello dire che chi lavora non sotto il capo diretto ma all’interno della fabbrica sociale è sfruttato come gli altri lavoratori. Il problema sorge quando la lotta precaria si rivela una lotta reazionaria che vuole tornare a una stabilità del passato. Direi che ci sono lotte molto interessanti in corso in questo momento in Europa e nel mondo, a cominciare da quelle “precarie”, che in America Latina chiamiamo “lavoratori marginali” o “settore informale”, che comprende anche i contadini , non solo quelle città emarginate (e questo per noi è molto importante). In quest’area troviamo uno scrigno di forme organizzative per la trasformazione della società. Direi che qui, come in Italia, Francia o Germania, la maggior parte dei lavoratori che sono stati precari fin dall’inizio, non solo per la recente crisi, quelli che non hanno mai avuto un lavoro non potrebbero sopravvivere senza organizzazione. Un operaio o impiegato può vivere da solo come individuo e occasionalmente essere al pub con altri. Al contrario, coloro che sono veramente precari, e noi li chiamiamo “informali”, non possono vivere senza un’organizzazione sociale: mantengono un “noi”, una struttura organizzativa, per la loro sopravvivenza. Quindi hanno creato diverse possibilità di esistenza al di là del capitalismo. Non per ideologia, ma per sopravvivenza, creano qualcosa che non può essere risolto dal capitalismo. Questo è dato in Europa e nel mondo: un insieme di fantasie sociologiche e politiche che ora possiamo coltivare ed estendere ad altri regni. Coloro che ora sono a porte chiuse, come i sindacati e i lavoratori tradizionali, possono imparare da questo. Oggi, la continuazione della lotta nei termini tradizionali della lotta sindacale non ha futuro, nessuna prospettiva, né possibili vittorie. Quindi, invece di riproporre questo modo tradizionale di lavorare e agire, i sindacati, ma anche le classiche organizzazioni di partito, dovrebbero rivolgere lo sguardo a queste persone vulnerabili per vedere come sono organizzate. Solo così trovano nelle società avanzate uno scrigno di diverse organizzazioni che possiamo chiamare sfere comunitarie.
Michalis “Mikis” Mavropoulos info.comune

“Evangelista zombi malvagio. Esperto di pancetta. Fanatico dell’alcol. Aspirante pensatore. Imprenditore.”